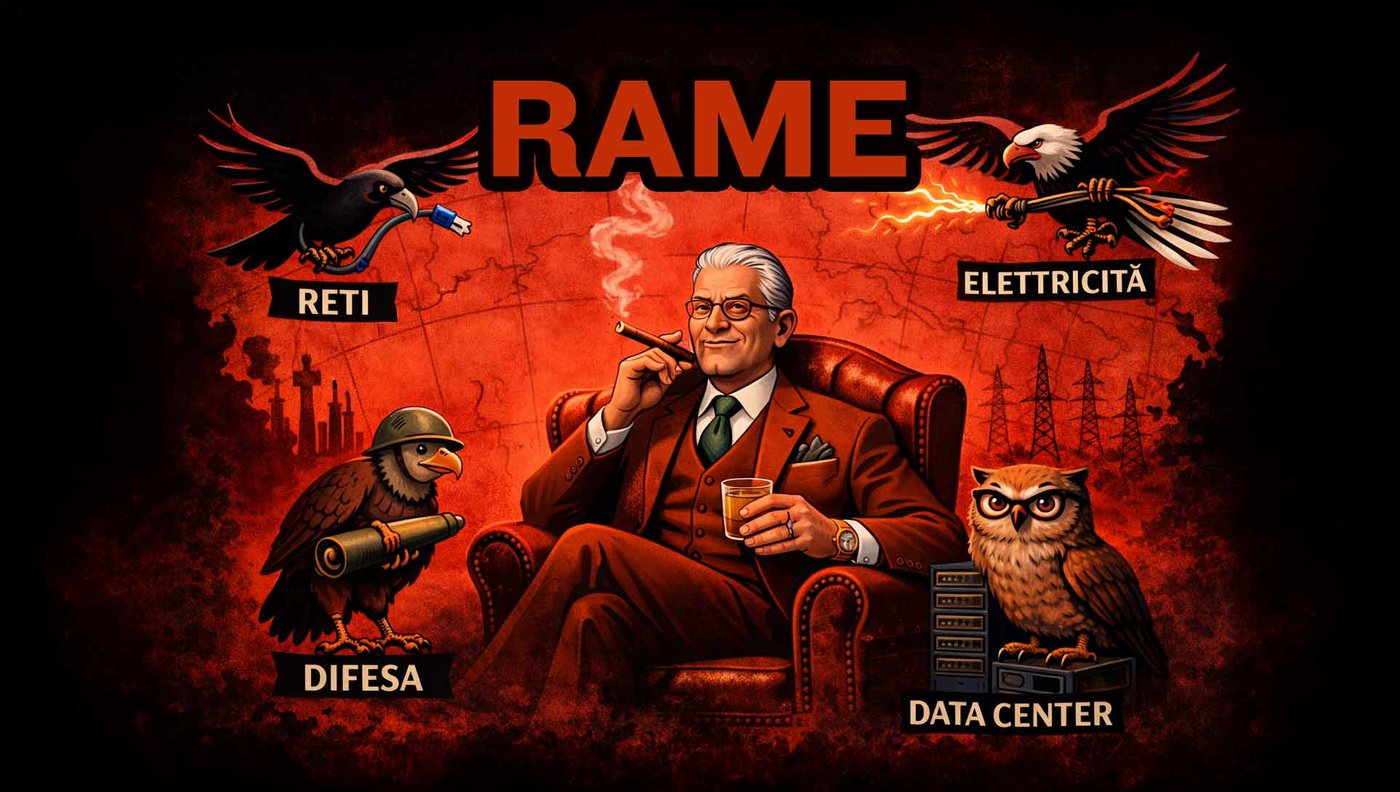Netanyahu a Mar-a-Lago: l’alleanza che resta, ma scricchiola
La visita di Benjamin Netanyahu a Donald Trump in Florida è stata letta come l’ennesima consacrazione del rapporto speciale tra Stati Uniti e Israele. Abbracci, elogi reciproci, medaglie simboliche. Netanyahu “eroe”, Trump prossimo vincitore del “Premio Israele”. Tutto perfetto, in superficie. Sotto, però, si muove qualcosa di molto meno rassicurante.
Negli Stati Uniti il sostegno a Israele non è più un riflesso automatico. Sta crescendo uno scetticismo diffuso, soprattutto nel mondo MAGA, dove la paura di nuove guerre “straniere” alimenta una stanchezza profonda verso l’alleato mediorientale. Non è un dettaglio marginale: quando Tucker Carlson parla apertamente di decine di migliaia di bambini uccisi a Gaza, o quando Megyn Kelly riconosce la spaccatura della destra americana su Israele, il messaggio è chiaro. Il tabù si è rotto.
I segnali politici sono già visibili. Dichiarazioni come quelle di Marjorie Taylor Greene — “non voglio pagare per un genocidio in un Paese straniero” — non sarebbero state concepibili solo pochi anni fa. E quando Trump confida a un donatore che “la mia gente sta iniziando a odiare Israele”, non sta facendo analisi geopolitica: sta leggendo i sondaggi.
Le ragioni vanno oltre la morale e l’umanitarismo. Il Medio Oriente pesa sempre meno nella gerarchia strategica americana. Gli Stati Uniti non dipendono più dall’energia della regione come un tempo, e la minaccia del terrorismo islamico è stata sostituita, nella percezione di Washington, dal rischio di conflitti tra grandi potenze e di escalation nucleare. Israele non è più visto come un avamposto indispensabile, ma come un potenziale fattore di trascinamento in guerre che molti americani non sentono proprie.
Questo non significa che il sostegno USA sparirà domani. Ma diventerà più condizionato, più transazionale. Il memorandum sugli aiuti militari scade nel 2028 e potrà essere rinegoziato in termini meno generosi. Soprattutto, la garanzia di sicurezza “implicita” americana — quella che ha sempre fatto la differenza — potrebbe lentamente evaporare.
Nel breve periodo Israele resta militarmente dominante nella regione. Ma buona parte della sua deterrenza è stata costruita sull’ombrello statunitense. Se quell’ombrello si chiude, anche solo a metà, Gerusalemme dovrà compensare altrove. Gli Accordi di Abramo hanno dimostrato una sorprendente resilienza, e la cooperazione militare con i Paesi arabi è cresciuta persino durante la guerra di Gaza. Tuttavia, questi alleati condividono l’avversione per l’Iran, non l’angoscia esistenziale israeliana. Sono più pronti a trattare, a mediare, a convivere.
Il vero nodo è qui. Israele potrà contare sempre più sulla regione. Ma potrebbe dover imparare, per la prima volta dopo decenni, a fare i conti con l’idea di affrontare le sue sfide di sicurezza più gravi non più con l’America alle spalle, ma — almeno in parte — da solo.
È forse in quest’ottica che va letto il progetto Iron Beam. La tecnologia a energia diretta può effettivamente alterare la dinamica offesa–difesa, perché toglierebbe a Israele una dipendenza strutturale dagli Stati Uniti, giudicati un alleato prezioso ma volubile.